 Ludovica Criscitiello è giornalista professionista dal 2011 e videomaker da due anni. Vive a Firenze dove scrive articoli, gira e monta video per La Nazione. Ha lavorato come addetto stampa a Roma per alcune associazioni e si muove da sempre nel campo della comunicazione. Si è laureata in Comunicazione d’Impresa e ha fatto il master di giornalismo a Napoli per iscriversi all’albo dei professionisti. A questo ha aggiunto anche i video perché si è convinta che una buona dose di immagini unita alla scrittura può fare davvero tanto. Trai temi di cui adora parlare, quelli sulla diversità e l’inclusione hanno la precedenza. Crede che lo scopo per fare del buon giornalismo sia quello di dare voce a chi, come Elisa Vavassori, nel suo piccolo fa qualcosa di grande, che può insegnare e ispirare anche altri. Raccontare storie che valgano la pena: è questa la mission di un giornalista.
Ludovica Criscitiello è giornalista professionista dal 2011 e videomaker da due anni. Vive a Firenze dove scrive articoli, gira e monta video per La Nazione. Ha lavorato come addetto stampa a Roma per alcune associazioni e si muove da sempre nel campo della comunicazione. Si è laureata in Comunicazione d’Impresa e ha fatto il master di giornalismo a Napoli per iscriversi all’albo dei professionisti. A questo ha aggiunto anche i video perché si è convinta che una buona dose di immagini unita alla scrittura può fare davvero tanto. Trai temi di cui adora parlare, quelli sulla diversità e l’inclusione hanno la precedenza. Crede che lo scopo per fare del buon giornalismo sia quello di dare voce a chi, come Elisa Vavassori, nel suo piccolo fa qualcosa di grande, che può insegnare e ispirare anche altri. Raccontare storie che valgano la pena: è questa la mission di un giornalista.
1. È una sfida partecipare a un Premio Giornalistico di un tema così specifico?
Credo che sia una sfida riuscire a saper raccontare con le parole giuste e la sensibilità adeguata temi così delicati. Come mi ha detto una volta una persona che ho intervistato “Determinate situazioni vanno raccontate con il cuore”.
2. Qual è la storia o il caso che hai raccontato che ti ha segnato di più?
In realtà è stata proprio la storia di Elisa Vavassori a colpirmi tanto. Sono l’impegno e la determinazione di questa persona ad essermi rimasti dentro perché nonostante la vita le abbia reso le cose davvero difficili, lei è riuscita a imporsi e a decidere del suo destino, molto più di tante persone (inclusa me stessa). E quando ho letto del premio ho pensato di proporre proprio questa perché ci tenevo a far conoscere Elisa.
3. Cosa può e/o deve essere oggetto di informazione?
Per me informare significa soprattutto denunciare quello che non va perché è attraverso gli organi di stampa che le istituzioni possono ricevere gli input giusti per poter agire di conseguenza. Ma significa anche al contempo mettere in luce gli aspetti positivi di qualunque realtà come quella di una ragazza che nonostante la malattia trova il coraggio di reagire e aiutare chi ha il suo stesso problema. O di chi vive in contesti di criminalità e delinquenza ma ha scelto una strada diversa.
4. La Comunicazione Sociale è un tema che trova spazio sulle testate?
Molto poco e infatti con Luce! che è questo canale nuovo della Nazione si cerca di dare spazio proprio a temi che normalmente vengono messi da parte: l’inclusione e la diversità in tutti gli ambiti.
5. Quali gli effetti dei Mass Media e New Media sulla comunicazione sociale?
Se utilizzati bene possono favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza su questi temi.
6. Esistono parole “giuste” per trattare la Comunicazione?
Si certo. Spesso noi giornalisti ce ne dimentichiamo, ma per indicare determinate categorie ad esempio esistono parole che devono essere usate per garantirne il rispetto come la locuzione “persone con disabilità” perché, come mi ha spiegato anche Elisa, i disabili sono prima di tutto persone. Come ogni potere anche quello delle parole è potente e, se usato nel modo sbagliato, inculca idee sbagliate nella mente delle persone.
7. Le notizie da divulgare e raccontare devono essere sempre nuove?
Non necessariamente, è possibile anche trattare argomenti di cui si è già parlato partendo da punti di vista differenti.
8. Le testate, oggi, secondo te sono prodotti commerciali o servizi pubblici?
Dovrebbero essere servizi pubblici, ma spesso purtroppo prevalgono interessi privati per motivi puramente economici e politici.
9. Che significa essere un buon giornalista?
Scegliere temi di cui non si parla per dare loro il giusto spazio e verificare sempre la veridicità di quello che si scrive per evitare di arrecare danni.
10. Come sei venuto a conoscenza del Premio?
Lo conosco da molti anni ma aspettavo la storia giusta per partecipare.

 Giornalista pubblicista dal 2015, nel 2012 si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo il trasferimento a Pavia, nel 2017, ha collaborato con la testata locale La Provincia Pavese occupandosi di cronaca, cultura e sport. Nel frattempo, si è occupata di tennis e basket presso delle riviste online e cartacee nazionali specializzate. Attualmente collabora da freelance con il Corriere della Sera nella sezione Cronaca Milano e Il Bello dell’Italia assieme ai blog La 27esima ora, Marilyn, Giornalisti nel pallone e Invisibili. Sempre da freelance, collabora anche con il quotidiano Domani e il magazine di basket femminile Pink Basket.
Giornalista pubblicista dal 2015, nel 2012 si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo il trasferimento a Pavia, nel 2017, ha collaborato con la testata locale La Provincia Pavese occupandosi di cronaca, cultura e sport. Nel frattempo, si è occupata di tennis e basket presso delle riviste online e cartacee nazionali specializzate. Attualmente collabora da freelance con il Corriere della Sera nella sezione Cronaca Milano e Il Bello dell’Italia assieme ai blog La 27esima ora, Marilyn, Giornalisti nel pallone e Invisibili. Sempre da freelance, collabora anche con il quotidiano Domani e il magazine di basket femminile Pink Basket.  Gabriella Cantafio è nata a Crotone il 28 agosto 1986. Laureata in Comunicazione Sociale presso l’Università degli Studi di Messina con Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media presso l’Università di Roma Tor Vergata. Giornalista, scrive di attualità e cultura su testate nazionali (Vanity Fair, Il Foglio, Il Giornale sezione OFF, Il Fatto Quotidiano). Collabora con aziende dei settori food e luxury (maison orafa Gerardo Sacco e Mulinum, la più grande startup agricola nata sul web) in qualità di addetto stampa. Dal 2012, collabora con il mondo associazionistico, nello specifico con il Consorzio di cooperative sociali Jobel di Crotone, alternando contratti a progetto a collaborazioni volontarie, sempre nell’ambito della comunicazione. Appassionata di libri, organizza eventi culturali. Giurata del Premio Letterario Caccuri nelle edizioni 2017-2018.
Gabriella Cantafio è nata a Crotone il 28 agosto 1986. Laureata in Comunicazione Sociale presso l’Università degli Studi di Messina con Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media presso l’Università di Roma Tor Vergata. Giornalista, scrive di attualità e cultura su testate nazionali (Vanity Fair, Il Foglio, Il Giornale sezione OFF, Il Fatto Quotidiano). Collabora con aziende dei settori food e luxury (maison orafa Gerardo Sacco e Mulinum, la più grande startup agricola nata sul web) in qualità di addetto stampa. Dal 2012, collabora con il mondo associazionistico, nello specifico con il Consorzio di cooperative sociali Jobel di Crotone, alternando contratti a progetto a collaborazioni volontarie, sempre nell’ambito della comunicazione. Appassionata di libri, organizza eventi culturali. Giurata del Premio Letterario Caccuri nelle edizioni 2017-2018.
 Ilaria Beretta, 28 anni, è giornalista professionista. Collabora con il bisettimanale d’attualità per bambini Popotus e il quotidiano Avvenire. Responsabile della comunicazione per un istituto religioso, scrive anche per “Mondo e Missione” e “Credere” dando spazio a buone pratiche ed esperienze di solidarietà. Nel 2017 ha vinto il Premio De Carli per l’informazione religiosa e nel 2020 una menzione speciale del Premio Benedetta D’Intino per la comunicazione della disabilità. Ha scritto il libro “Quello che le donne non dicono alla Chiesa” (Àncora, 2019) e ogni settimana registra il podcast per bambini “Le notizie della illy”.
Ilaria Beretta, 28 anni, è giornalista professionista. Collabora con il bisettimanale d’attualità per bambini Popotus e il quotidiano Avvenire. Responsabile della comunicazione per un istituto religioso, scrive anche per “Mondo e Missione” e “Credere” dando spazio a buone pratiche ed esperienze di solidarietà. Nel 2017 ha vinto il Premio De Carli per l’informazione religiosa e nel 2020 una menzione speciale del Premio Benedetta D’Intino per la comunicazione della disabilità. Ha scritto il libro “Quello che le donne non dicono alla Chiesa” (Àncora, 2019) e ogni settimana registra il podcast per bambini “Le notizie della illy”. Giornalista marchigiano classe 1989, in oltre 17 anni di giornalismo si occupa di argomenti quali cronaca e sport. Laureato in Economia e Commercio (110 e lode), ha lavorato come telecronista, radiocronista e inviato, rivestendo l’incarico di responsabile ufficio stampa (Jesina Calcio) e collaborando con magazine, settimanali, quotidiani cartacei (Corriere Adriatico) e online. Ha partecipato negli anni a eventi sportivi come Gran Galà Calcio Serie A Milano, Gran Galà Calcio Serie B, Sport Digital Marketing Festival e Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi. Nel suo cv un Master Sport – Digital Marketing & Communication del Sole 24 Ore. Risulta tra i vincitori del premio Overtime Web Festival 2018 (miglior articolo sport individuali), si conferma nel 2019 e ottiene il premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara 2019 (menzione speciale all’Odg – Napoli). È tra i vincitori del concorso letterario Racconti Sportivi 2019 (Centro Sportivo Italiano – Historica) la cui cerimonia di premiazione si è svolta in occasione della settimana del Salone del Libro di Torino 2019 e al Teatro Arena di Bologna. Si ripete nell’edizione 2020 di Racconti Sportivi. È stato premiato a Maggio 2019 come miglior giornalista under 30 Premio Renato Cesarini 2019. Nominato tra i migliori 30 millennials d’Italia 2019, vincitore del prestigioso Myllennium Award all’Accademia di Francia a Roma in ambito comunicazione sportiva. A settembre 2019 riceve la menzione d’onore al Premio Letterario Città di Ascoli Piceno. Ha all’attivo interventi e docenze in giornalismo e comunicazione in università e master (Roma, Bologna, Ancona, Macerata). A luglio 2020 viene premiato dal Ministro Sport Vincenzo Spadafora al Myllennium Award 2020 (Accademia di Francia – Villa Medici), alla presenza del Presidente Coni Giovanni Malagò, e ottiene il premio speciale di migliore giornalista giovane al Premio Cesarini ad agosto 2020. A Torino vince sempre nel 2020 il Premio Giovanni Arpino – Inedito dedicato alla letteratura sportiva. Vincitore del titolo di miglior blogger sportivo 2020 (Blog dell’Anno 2020) e del premio di giornalismo sportivo Simona Cigana 2020 (Friuli Venezia Giulia). Vince anche la menzione speciale al Premio Internazionale Città di Sarzana e al Premio Santucce Storm Festival sempre in ambito storytelling sportivo. Autore del libro “Happy Hour da fuoriclasse al Bartocci”.
Giornalista marchigiano classe 1989, in oltre 17 anni di giornalismo si occupa di argomenti quali cronaca e sport. Laureato in Economia e Commercio (110 e lode), ha lavorato come telecronista, radiocronista e inviato, rivestendo l’incarico di responsabile ufficio stampa (Jesina Calcio) e collaborando con magazine, settimanali, quotidiani cartacei (Corriere Adriatico) e online. Ha partecipato negli anni a eventi sportivi come Gran Galà Calcio Serie A Milano, Gran Galà Calcio Serie B, Sport Digital Marketing Festival e Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi. Nel suo cv un Master Sport – Digital Marketing & Communication del Sole 24 Ore. Risulta tra i vincitori del premio Overtime Web Festival 2018 (miglior articolo sport individuali), si conferma nel 2019 e ottiene il premio giornalistico nazionale Mimmo Ferrara 2019 (menzione speciale all’Odg – Napoli). È tra i vincitori del concorso letterario Racconti Sportivi 2019 (Centro Sportivo Italiano – Historica) la cui cerimonia di premiazione si è svolta in occasione della settimana del Salone del Libro di Torino 2019 e al Teatro Arena di Bologna. Si ripete nell’edizione 2020 di Racconti Sportivi. È stato premiato a Maggio 2019 come miglior giornalista under 30 Premio Renato Cesarini 2019. Nominato tra i migliori 30 millennials d’Italia 2019, vincitore del prestigioso Myllennium Award all’Accademia di Francia a Roma in ambito comunicazione sportiva. A settembre 2019 riceve la menzione d’onore al Premio Letterario Città di Ascoli Piceno. Ha all’attivo interventi e docenze in giornalismo e comunicazione in università e master (Roma, Bologna, Ancona, Macerata). A luglio 2020 viene premiato dal Ministro Sport Vincenzo Spadafora al Myllennium Award 2020 (Accademia di Francia – Villa Medici), alla presenza del Presidente Coni Giovanni Malagò, e ottiene il premio speciale di migliore giornalista giovane al Premio Cesarini ad agosto 2020. A Torino vince sempre nel 2020 il Premio Giovanni Arpino – Inedito dedicato alla letteratura sportiva. Vincitore del titolo di miglior blogger sportivo 2020 (Blog dell’Anno 2020) e del premio di giornalismo sportivo Simona Cigana 2020 (Friuli Venezia Giulia). Vince anche la menzione speciale al Premio Internazionale Città di Sarzana e al Premio Santucce Storm Festival sempre in ambito storytelling sportivo. Autore del libro “Happy Hour da fuoriclasse al Bartocci”.  Erika Antonelli ha 29 anni e una laurea magistrale in Interpretariato e traduzione che le ha fatto capire due cose: in tedesco la parola “Heimweh” è intraducibile e io non voglio fare l’insegnante. Prima di iscriversi al master in Giornalismo e Comunicazione multimediale della Luiss (Roma) ha insegnato tedesco e inglese in una scuola di lingue e vissuto tre anni in Austria. A 28 anni è tornata in Italia (vedi “Heimweh” di cui sopra) ed era intrappolata in una professione poco appagante. Ha scelto di iscriversi alla scuola di giornalismo, cosciente che senza borsa di studio non se la sarebbe potuta permettere. Ha vinto la prima e ringrazia il giorno in cui per caso ha letto il bando di iscrizione. Ha fatto uno stage presso CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Partecipa a questo premio perché trova che la comunicazione sociale sia la sintesi perfetta del lavoro giornalistico: bisogna scegliere con cura le parole, ma la storia vale la fatica.
Erika Antonelli ha 29 anni e una laurea magistrale in Interpretariato e traduzione che le ha fatto capire due cose: in tedesco la parola “Heimweh” è intraducibile e io non voglio fare l’insegnante. Prima di iscriversi al master in Giornalismo e Comunicazione multimediale della Luiss (Roma) ha insegnato tedesco e inglese in una scuola di lingue e vissuto tre anni in Austria. A 28 anni è tornata in Italia (vedi “Heimweh” di cui sopra) ed era intrappolata in una professione poco appagante. Ha scelto di iscriversi alla scuola di giornalismo, cosciente che senza borsa di studio non se la sarebbe potuta permettere. Ha vinto la prima e ringrazia il giorno in cui per caso ha letto il bando di iscrizione. Ha fatto uno stage presso CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Partecipa a questo premio perché trova che la comunicazione sociale sia la sintesi perfetta del lavoro giornalistico: bisogna scegliere con cura le parole, ma la storia vale la fatica. 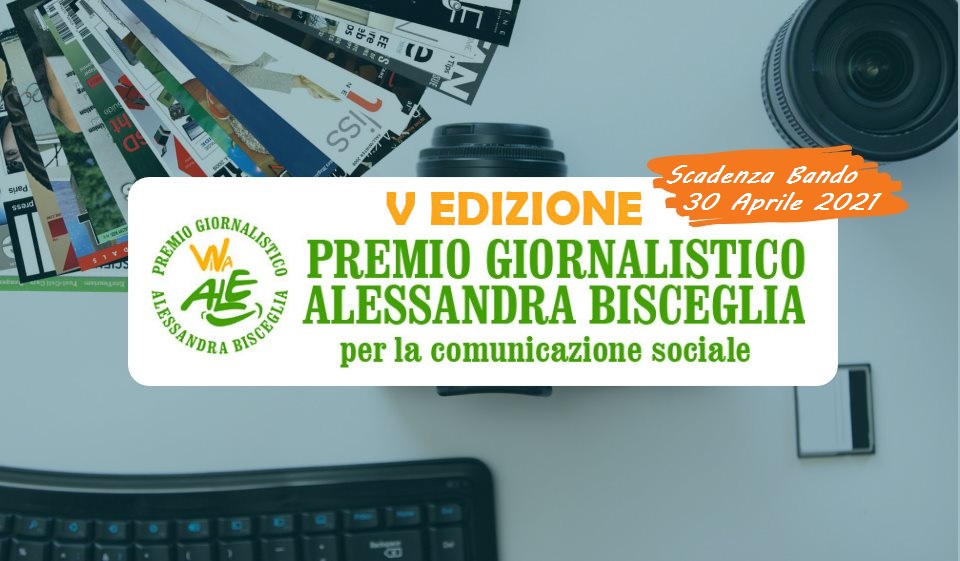
 Nel nostro piccolo, la Fondazione ViVa Ale — che è già un modo di dedicarsi a chi fatica — non ha mai mollato, in questo anno, dal marzo del 2020. Abbiamo cercato di organizzarci, secondo la nuova realtà. Abbiamo offerto consulenze online, psicologiche e mediche.
Nel nostro piccolo, la Fondazione ViVa Ale — che è già un modo di dedicarsi a chi fatica — non ha mai mollato, in questo anno, dal marzo del 2020. Abbiamo cercato di organizzarci, secondo la nuova realtà. Abbiamo offerto consulenze online, psicologiche e mediche.